Lavorare per la coedizione: un traduttore, nuove competenze?
Fabio Regattin, Università di Bologna
RIASSUNTO
La coedizione internazionale, un fenomeno emergente in ambito editoriale, permette a editori di diversi paesi di dividere i costi legati alla produzione di volumi illustrati. Il tipo di meccanismi che questo genere di edizione implica si rivela interessante anche per il traduttore e per la traduzione. Questo contributo, a carattere introduttivo, cercherà di fornire una descrizione della pratica che ne metta in luce gli aspetti economici, etici (in senso lato) e pratici.
PAROLE CHIAVE
Coedizione, editoria, politiche editoriali, mercato editoriale, globalizzazione.
Abstract
International co-edition, a growing practice in the editorial world, allows publishers from different countries to share the costs involved in the production of illustrated books. The questions that this type of publishing stimulates prove to be interesting for translators and, in a wider sense, for translation too. This introductory overview seeks to give a description of the practice, concentrating on its economic, ethical (in a broad sense) and practical aspects.
KEYWORDS
Co-edition, publishing, editorial policies, editorial market, globalisation, globalization.
1. Obiettivo dello studio
Queste righe partono dalla constatazione dell'assenza di studi che considerino quello che, in Italia e altrove, appare come un fenomeno emergente all'interno del mondo editoriale: la coedizione internazionale. Questa pratica consente di abbattere i costi e i tempi di produzione di alcune categorie di libri, assicurando agli editori che se ne servono un vantaggio sicuro rispetto alle produzioni ex novo ma, d'altra parte, rischia di limitare la varietà e l'originalità delle produzioni editoriali. Riteniamo che la coedizione internazionale presenti un certo interesse anche dal punto di vista traduttologico, vista la sua importanza crescente, il suo carattere plurilingue e gli aspetti particolari che presenta anche per il lavoro del traduttore. Il nostro contributo, a carattere introduttivo, cercherà di fornire una descrizione della coedizione che prenda in considerazione diversi suoi aspetti (pratico, editoriale, economico, etico) concentrandosi in seguito sulle conseguenze che essi implicano per il lavoro del traduttore. Infine, saranno brevemente dibattuti argomenti quali la possibilità di una formazione specifica per i futuri traduttori operanti in quest'ambito e la possibilità di occuparsi a monte di alcuni dei problemi (problemi talvolta non risolti per semplice disinteresse) che questo genere di operazione pone a tutti gli attori della filiera editoriale e al traduttore in particolare.
2. La coedizione: definizione, caratteristiche
Il primo punto da stabilire, parlando di 'traduzione per la coedizione,' è di carattere terminologico. Che cos'è la coedizione? La pratica è relativamente recente ma, per quanto rappresenti ancora oggi una frazione ridotta della produzione libraria italiana, appare in crescita. Secondo i dati riportati da Giovanni Peresson (Peresson 2005: 35), tra il 1997 e il 2003 i titoli così pubblicati sono passati da 956 a 1484, e la percentuale sul totale dei libri editi nel paese dall'1,8 al 2,7%. Un ruolo ancora marginale, come dimostra anche l'assenza di definizioni standard da parte dei principali organi di monitoraggio del nostro paese; ancora pochi anni fa, questi ne offrivano una semplice descrizione, a quanto ci è dato sapere mai aggiornata ("La coedizione riguarda l'insieme di pubblicazioni prodotte con il contributo di più editori," Arosio 2002: 7). Detta definizione, in particolare per quanto riguarda la coedizione internazionale, appare insufficiente e trascura gli aspetti che, dal nostro punto di vista, appaiono più interessanti. Una visione forse più completa viene dalla Francia, dal Syndicat National de l'Édition:
Il s'agit le plus souvent d'éditeurs qui s'associent pour un projet de livre illustré, afin de partager les frais de création et les frais fixes de fabrication. L'éditeur détenteur des droits cède à un ou plusieurs éditeurs étrangers les droits d'édition pour telle ou telle langue et/ou territoire. (SNE senza data. I corsivi sono nostri)
Questa definizione evidenzia alcune caratteristiche interessanti, che permettono di meglio comprendere l'operazione in questione. La coedizione avviene generalmente tra editori di diversi paesi (gli scarsi dati che abbiamo reperito — vedi ancora Peresson 2005 — dimostrano che la percentuale delle coedizioni internazionali1 sul totale di questa forma di edizione è stata, negli anni, costantemente superiore al 50%) e avviene all'interno di un mercato piuttosto specifico: quello dei libri illustrati di vario genere (libri d'arte, prontuari, ricettari, manuali per il fai-da-te di varie tipologie, coffee table books, libri illustrati per l'infanzia e così via). Infine, si ricorre alla coedizione per ragioni economiche, in quanto la condivisione delle spese di stampa e di produzione permette di abbassare in misura anche notevole i costi vivi di realizzazione dei libri. La coedizione può assumere due modalità differenti: quella, più frequente, della semplice cessione dei diritti di sfruttamento di un'opera, peraltro già prodotta, all'interno di un determinato mercato e quella, più rara, della vera e propria coproduzione, in cui due o più case editrici collaborano alla realizzazione del prodotto editoriale dalla sua concezione alla stampa.
Ma per quale motivo questa pratica gode di un certo successo proprio nell'ambito del libro illustrato? La questione, come spesso accade, è legata essenzialmente a fattori di carattere economico. Rispetto a quanto avviene con i semplici volumi in monocromia, gli oneri legati alla produzione di questo tipo di libri lievitano notevolmente già al momento della concezione dell'opera, quando è necessario impegnarsi nella ricerca iconografica e nell'acquisto delle immagini necessarie, oltre che nella concezione grafica dell'intera opera, pagina per pagina2 (le immagini presenti andranno infatti disposte in modo accattivante e coerente con il tipo di volume che si desidera realizzare: dal punto di vista grafico, il lavoro richiede un impegno molto maggiore rispetto alla semplice impaginazione di un testo). Altra importante fonte di spesa è il processo di realizzazione materiale dei volumi. La stampa dei libri a colori viene infatti effettuata, interamente o quasi, in quadricromia, un fatto che comporta diverse conseguenze: se per stampare un volume composto da solo testo è necessario un unico passaggio del foglio attraverso la macchina a stampa offset, nel caso in cui nella pagina sia presente anche un'unica immagine policroma il numero dei passaggi aumenta a un minimo di quattro (quelli necessari per ottenere la maggior parte delle sfumature di colore attraverso la combinazione di ciano, magenta, giallo e nero). Enrico Mistretta elenca i costi aggiuntivi che deve sobbarcarsi chi decide di produrre un libro a colori:
Non bisogna solo approntare le (almeno) quattro pellicole della quadricromia, ma il foglio di carta deve passare quattro volte nella macchina a stampa, sotto i rulli inchiostrati con i quattro colori. [...] Si comprende ora meglio perché siano così alti i costi di preparazione della stampa: il montaggio delle pagine, la produzione delle pellicole fotolito prima e delle lastre poi, la preparazione della macchina a stampa (lavaggio, registrazione del formato della carta, inserimento dell'inchiostro giusto) sono operazioni lunghe, e quindi costose, che si ammortizzano poi rapidamente, oltre le prime migliaia di copie stampate, data l'alta velocità con cui marcia la macchina offset. (Mistretta 2006: 136-137)
Proprio grazie alla coedizione internazionale, le maggiori difficoltà elencate qui sopra possono essere in gran parte aggirate. L'accorgimento che consente di ottenere i risparmi più sostanziali è legato proprio alla produzione dei volumi e in particolare alla stampa in quadricromia; e, paradossalmente, passa attraverso l'aumento, in una prima fase, delle lastre di stampa, che da quattro divengono cinque. Viene infatti creato un apposito livello, su una pellicola (e quindi una lastra) separata, che contiene il solo testo (tale livello è in genere chiamato text black); i quattro colori che vanno a comporre le immagini formano invece le quattro lastre classiche (si vedano a questo proposito le immagini 1, 2 e 3).
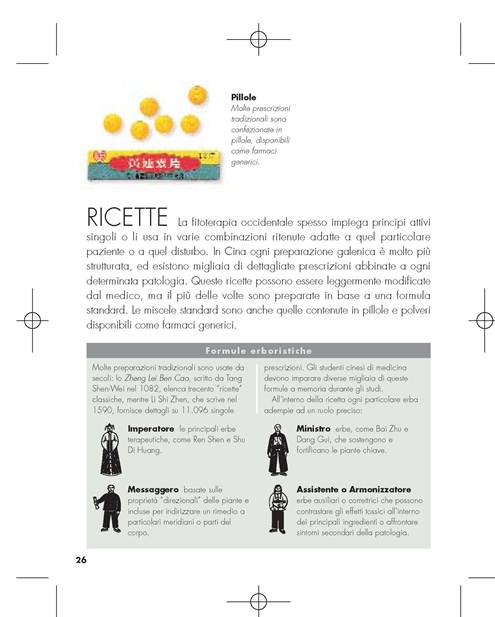
Immagine 1: L'impaginato completo di un testo illustrato pubblicato come coedizione
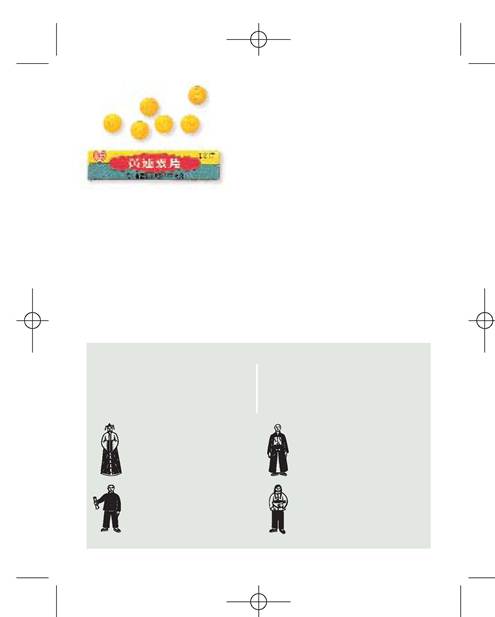
Immagine 2: Il risultato della sovrapposizione dei quattro colori classici senza testo (la parte comune a tutte le edizioni)
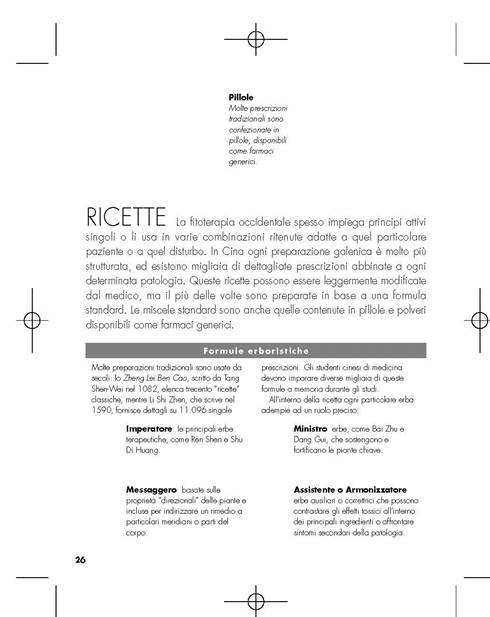
Immagine 3: La lastra del text black, che viene sostituita a seconda delle edizioni e sovrapposta alle quattro delle immagini
A questo punto, per ottenere varie edizioni dello stesso volume in altre lingue, sarà possibile riutilizzare queste ultime quattro lastre modificando soltanto la quinta, quella del text black appunto. Si vede subito come, all'aumentare delle lingue coinvolte, il numero di lastre necessarie alla produzione del libro cresca molto lentamente. Se per produrre il volume in un'unica lingua sono necessarie cinque lastre, con sei potremo pubblicare l'opera in due lingue, con sette lastre in tre lingue e così via, ogni lingua aggiuntiva implicando la preparazione di una sola lastra in più. Gli altri costi di produzione risultano ugualmente abbattuti: la ricerca iconografica, la concezione del volume a livello grafico, l'acquisto delle immagini (o la loro realizzazione da parte dell'editore stesso: si pensi alla voce relativa alla concezione delle mappe nell'elenco delle competenze indicato nella nota n. 2) sono tutte operazioni che vengono svolte una volta sola e che non devono essere replicate all'aumentare delle lingue coinvolte. Stampando contemporaneamente il volume in più edizioni nazionali, inoltre, è possibile raggiungere più facilmente il punto limite (run on) che, come sottolinea Mistretta, viene spesso toccato, visti gli alti costi di produzione, solo dopo la produzione di alcune migliaia di copie di un volume.3
Fronte a un vantaggio economico assolutamente rilevante, la pratica che ci interessa impone però diversi obblighi, che ogni coeditore è costretto a sobbarcarsi. Il primo e più ovvio4 è quello relativo all'imposizione, da parte del creatore originale del volume, di uno stile e di un formato unico per le edizioni di tutti i paesi, senza la minima possibilità di adattamento grafico: per ottenere il risparmio voluto, infatti, ogni singola immagine dell'originale deve essere presente, ed esserlo nell'esatta posizione occupata nell'originale, anche nelle versioni in altre lingue, al pari degli eventuali box di testo o accorgimenti grafici a colori di qualunque tipo. Il secondo riguarda invece le tempistiche: per ottenere il risparmio maggiore, e talvolta per poter procedere alla produzione evitando un passivo certo — dato che il punto limite nella produzione di un libro illustrato è spesso raggiunto solo dopo svariate migliaia di copie — la stampa dei volumi nelle diverse lingue deve avvenire in contemporanea. Gli editori dei diversi paesi saranno quindi assoggettati alle scadenze imposte dal "membro forte" del gruppo, ossia l'editore che ha prodotto il volume nella sua veste originale. Tale aspetto può rendere molto stretti i tempi a disposizione per la preparazione delle diverse edizioni, soprattutto quando il libro viene pubblicato come coproduzione o comunque in contemporanea in originale e nelle varie traduzioni, un fatto sempre più comune. In questo caso si scontrano in genere due esigenze contrastanti: quella dell'editore originale, che punta a pubblicare il volume il prima possibile, e quella degli editori partner, che hanno bisogno di negoziare tempi accettabili per tradurre ed eventualmente adattare il testo di partenza. Per velocizzare le operazioni di produzione è prassi sempre più diffusa la cessione, dall'editore originale ai coeditori, delle parti di testo già pronte (capitoli, didascalie, box) man mano che queste vengono completate, prima che l'intero volume sia stato integralmente scritto e, spesso, prima anche della revisione e dell'editing interni, con tutte le conseguenze che questo fatto può implicare riguardo alla qualità dei volumi così ottenuti.5 Una volta stabilita una data per la stampa, comunque, i ritardi non sono ammessi, perché la mancata consegna dei file di stampa da parte di uno solo dei partner della coedizione può bloccare il procedimento per tutti (si veda, a questo proposito, Owen 2001: 168-170); il prezzo da pagare per una casa editrice, in questo caso, potrebbe essere di natura pecuniaria (il rimborso agli altri editori delle perdite dovute al ritardo nella stampa) oppure consistere nella sospensione della stampa delle proprie copie fino all'eventuale ristampa del volume o a una coedizione con nuovi partner di nuovi paesi, con un ritardo per la pubblicazione anche molto pesante, quantificabile in diversi mesi o addirittura anni. La necessità di procedere alla traduzione 'in corso d'opera' e l'assoluta inderogabilità delle scadenze sono fattori che, in entrambi i casi, vanno frequentemente a scapito della qualità complessiva del lavoro svolto. Torneremo infra anche su questo punto, che però meritava una citazione già in questa fase, in quanto dipendente dalle meccaniche produttive del settore.
Come dimostrano le sue peculiarità, l'ambito della coedizione, pur rimanendo all'interno del più vasto mondo editoriale, se ne discosta in diversi modi — un fatto che porta con sé importanti conseguenze anche dal punto di vista traduttologico, tanto per quanto attiene ai meccanismi di realizzazione delle traduzioni (e agli effetti che essi comportano sul lavoro del traduttore) come dal punto di vista ideologico ed etico.
3. La coedizione: un caso esemplare di globalizzazione
La coedizione presenta evidenti aspetti positivi, che la rendono un'importante risorsa nel panorama editoriale; il vantaggio economico implicato da questo tipo di operazione offre infatti benefici sicuri per l'editore, che può permettersi di pubblicare volumi che sarebbero altrimenti al di fuori della sua portata, ma anche per l'utente finale, che può accedervi a un costo più basso di quello delle produzioni ex novo (come abbiamo visto sopra, talvolta questo vantaggio rischia di essere ottenuto a scapito della qualità del prodotto-libro finito). L'effetto più evidente della riduzione dei costi consiste ovviamente nell'ampliamento della produzione, con una moltiplicazione di titoli e di volumi a disposizione dell'utente interessato. Il vantaggio è sensibile anche per l'editore, che ottiene la possibilità di ampliare in tempi brevi e a costo ridotto il proprio catalogo, aumentando così la varietà delle proprie proposte senza dover per questo ricorrere alle diverse professionalità necessarie a realizzare ex novo testi molto diversi tra loro.
Questi fatti, apparentemente positivi, portano tuttavia con sé anche alcune conseguenze problematiche, sollevando domande con cui la traduttologia si è già, in parte, confrontata in altri ambiti; in particolare, sembra riproporsi la questione dell'egemonia culturale, nel senso venutiano del termine,6 di alcuni paesi a scapito di altri. La situazione attuale vede pochi paesi esportatori di nuovi testi, fronte a un numero crescente di importatori: il flusso produttivo contempla infatti da una parte pochi grandi gruppi anglosassoni (Crown, società facente parte del gruppo Random House; Conran-Octopus e Ivy Press, a loro volta parte di Hachette; Murdoch Books, Phaidon, Quarto, Thames & Hudson e pochi altri), e dall'altra una molteplicità di coeditori in tutti gli altri paesi, soprattutto asiatici ed europei. Il perché è, ancora una volta, facilmente spiegato: visti gli alti costi imposti dall'edizione dell'illustrato, la concezione di nuovi titoli può essere appannaggio dei soli editori che abbiano a disposizione un numero sufficiente di possibili clienti; a questo proposito, il mercato anglofono è forse l'unico ad assicurare un bacino di utenza adeguato (composto non solo dai parlanti madrelingua ma anche da eventuali lettori per cui l'inglese sia una L2). È d'altronde per questo stesso motivo che numerosi editori di illustrati provenienti da altri paesi, se decidono di produrre un testo in proprio, affiancano frequentemente una traduzione inglese al testo nella lingua d'origine, sperando in questo modo di ampliare il numero dei potenziali acquirenti. È significativo, a questo proposito, che l'unico editore non anglosassone di primo piano sia il tedesco Taschen, che tuttavia sfrutta 'in proprio' gli stessi meccanismi che rendono possibile la coedizione: produce nuovi titoli prevalentemente in inglese e li pubblica poi in diversi paesi, adattando i testi con il meccanismo già visto delle quattro lastre + text black; l'unica differenza di rilievo è data dal fatto che le varie edizioni sono tutte pubblicate dall'editore, che assume in prima persona tutti i rischi e i benefici dell'impresa, e non cedute a vari operatori sui mercati nazionali.
Se, dunque, la coedizione permette un ampliamento considerevole dei titoli a disposizione del lettore, dall'altro è alto il rischio che questi titoli appaiano fortemente omologati, tanto dal punto di vista grafico (il possibile sviluppo di un 'pensiero estetico unico' non sarà trattato in queste righe, ma va comunque tenuto in considerazione e meriterebbe di essere approfondito) quanto da quello concettuale. Si è visto in precedenza come il termine 'libro illustrato' raccolga una serie molto variegata di oggetti diversi: alcuni di essi possono avere un effetto pratico sulla vita o sui comportamenti delle persone (si pensi per esempio ai libri di ricette, o ai manuali relativi a determinate discipline o attività sportive); altri possono fornire loro una serie di nozioni (libri divulgativi di argomento storico, scientifico, artistico e così via). In entrambi i casi, la visione dei comportamenti da adottare o della scala di valori da attribuire a determinati aspetti all'interno dell'ambito trattato sarà per forza di cose mediata dalla cultura in cui il libro è stato concepito e dal pubblico d'origine per cui è pensato. Una raccolta di ricette sulla cucina regionale italiana, un manuale sui fondamenti del tai chi, un volume sui cento personaggi più importanti del XX secolo o sulla storia delle civiltà antiche riceveranno un trattamento diverso a seconda che il libro sia pensato in un un paese o un altro per il pubblico di un paese o di un altro. È vero che un simile aspetto non emerge solo nel campo dell'illustrato ma in quello editoriale in senso ampio, tuttavia il ricorso ad adattamenti locali e all'eventuale localizzazione dei testi risulta complicato, in questo caso, dalla presenza di un layout che va seguito senza deviazioni, e che non permette di integrare i testi con informazioni più interessanti per il mercato locale. Chi scrive ha lavorato, per esempio, alla revisione di un volume dedicato al mondo del vino, nei suoi vari aspetti; il libro, originariamente pensato per il pubblico americano, consisteva in una parte introduttiva dedicata alle tecniche di degustazione, seguita da un'accurata descrizione dei vini e dei produttori più rinomati di tutto il mondo, suddivisi per paese. Se le cantine e i vitigni francesi potevano contare su una ventina di pagine, i vini italiani erano risolti in otto pagine — due in meno di quelle dedicate ai vini statunitensi e canadesi. Questa immagine del panorama vitivinicolo mondiale è passata senza modifiche (a causa dell'impostazione del layout) non solo nel nostro paese, ma anche in tutti quelli nei quali un editore locale ha deciso di pubblicare il libro.7
Quello che allo stato attuale delle cose appare come uno squilibrio del sistema potrebbe in futuro essere almeno in parte appianato proprio attraverso il meccanismo della coedizione o, più facilmente, della coproduzione vera e propria, grazie alle quali anche case editrici periferiche potrebbero riuscire a finanziare progetti editoriali da diffondere al mondo intero, contribuendo a gettare uno sguardo altro, dall'interno, su determinati aspetti del mondo quali, per esempio, il design o l'arte locali. Un esempio di integrazione riuscita del meccanismo della coedizione è rappresentato, nel mondo dell'illustrato per l'infanzia, da OQO, casa editrice galiziana che da una posizione geografica e linguistica relativamente periferica è riuscita a imporsi con successo su gran parte del mercato europeo. Le pubblicazioni di OQO avvengono in due forme, e sfruttano in entrambi i casi il procedimento della separazione delle lastre dei colori e del testo; l'editore realizza e pubblica autonomamente i propri testi in gallego, spagnolo, catalano, inglese e francese (ancora una volta le illustrazioni e il layout non variano, mentre cambiano le parti testuali); allo stesso tempo, accordi con case editrici basche e italiane permettono di diffondere i libri anche in queste aree linguistiche. La tiratura per ogni lingua è talvolta molto bassa (in Italia i volumi base della collana, pubblicati da Logos, si attestano attorno alle 5-600 copie in media, con valori compresi tra le 300 e le 1000 copie) ma a questo aspetto si compensa con un alto numero di lingue, che permette di superare agevolmente il run on e di produrre e diffondere, da un'area relativamente periferica, volumi dalla voce alternativa a quella 'egemonica,' in cui possono per esempio trovare spazio favole tradizionali galiziane o basche che in altro modo supererebbero solo con grande difficoltà i confini linguistici in cui sono normalmente costrette.
Questa complessità del rapporto tra traduzione e globalizzazione — il fatto che la prima possa, a seconda dei casi, essere tanto un'agente di promozione del pensiero egemonico come un metodo per contrastarlo, rendendo più accessibili le realtà culturali periferiche — è d'altronde stata già segnalata alcuni anni fa da Michael Cronin (cfr. Cronin 2003: 8-42), il cui pensiero in merito può essere adattato senza difficoltà anche all'ambito della coedizione.Lasciamo comunque questo argomento a chi vorrà svilupparlo, limitandoci qui a segnalare un aspetto che, se allo stato attuale delle cose appare prevalentemente negativo, potrebbe portare acqua al mulino della sovversione dei tradizionali rapporti di forza culturali.
4. La coedizione per il traduttore: traduzione, adattamento?
Perché una coedizione possa essere portata a termine con successo sono ovviamente necessarie figure che si occupino della produzione del testo nelle varie lingue in cui il volume viene pubblicato. Il lavoro che viene loro richiesto differisce tuttavia, sotto diversi punti di vista, da quello che ci si aspetta normalmente da un traduttore editoriale; per descriverne alcuni aspetti può essere utile ricorrere al concetto di "adattamento". Si sa che la frontiera che separa quest'ultimo dalla traduzione è alquanto porosa, tanto che diversi teorici concordano nel rinunciare direttamente al suo uso, riunendo i due termini (lo fa per esempio Christiane Nord, affermando che l'iperonimo "traduzione" può essere esteso a coprire trasformazioni e interventi di vario genere fintantoché "the target-text effect corresponds to the intended target-text functions" — cfr. Nord 1997: 93). Seguendo Georges Bastin, che si è occupato della questione in più occasioni, riteniamo invece che in determinati contesti il concetto di adattamento possa rivestire un'utile funzione distintiva. Bastin (2001: 5) definisce l'adattamento come "A text that is not accepted as a translation but is nevertheless recognized representing a source text of about the same length," qualificandolo ulteriormente come una "re-création" del testo di partenza, ri-creazione che per di più sarebbe "necessaria," imposta dalle condizioni stesse in cui si svolge l'operazione (Bastin 1993: 473).
Sembra che il lavoro per la coedizione possa essere fatto rientrare senza difficoltà in questa definizione: operare in quest'ambito pone infatti il traduttore di fronte a problemi che possono essere risolti solo grazie al ricorso a forme di resa diverse dalla traduzione in senso stretto. L'impossibilità di modificare il layout è, a questo proposito, il primo elemento da tenere in considerazione. In maniera variabile a seconda della coppia di lingue considerata, il traduttore si vedrà spesso obbligato a operare tagli testuali anche considerevoli per rimanere all'interno degli spazi a disposizione (si sa, per esempio, che testi paralleli nella coppia di lingue inglese/italiano possono avere lunghezze e ingombri sulla pagina che differiscono anche di un 15-20% 'a favore' dell'inglese).
Questo fatto mette in gioco a un tempo diverse questioni, la prima e più evidente delle quali è quella dell'autorialità: il traduttore assume un ruolo che, seppure non si possa considerare propriamente ri-creativo o autoriale in senso stretto, lo pone di fronte a scelte che ne avvicinano la figura a quella dell'editor. Investito del diritto-dovere di effettuare in prima persona, nella propria traduzione, tagli e modifiche all'originale, dovrà svolgere lo stesso lavoro compiuto da un editor sui manoscritti. Esiste però una differenza sostanziale. Nella stragrande maggioranza dei casi, il lavoro di editing è di tipo collaborativo: l'editor suggerisce modifiche e apporta cambiamenti al testo che gli viene sottoposto, ma tali variazioni sono poi supervisionate dall'autore, che in genere mantiene un certo potere decisionale e potrà scegliere se accettarle o meno. La posizione del traduttore è, in quest'ottica, meno confortevole. Sia per le tempistiche, sempre molto rapide, sia per il fatto che il testo originale è già in qualche modo 'chiuso,' questi sarà infatti costretto a prendere le proprie decisioni in maniera del tutto autonoma, senza che gli sia data la possibilità di interagire con l'autore e di discutere le proprie scelte con lui.
La responsabilità del traduttore è, più che altrove, anche di carattere etico: nei confronti dell'autore, certo, ma anche (e talvolta soprattutto) nei confronti del lettore. Questo aspetto non vale per ogni tipo di libro, ma molti dei volumi illustrati pubblicati secondo la modalità che ci interessa hanno un forte carattere conativo: l'esempio più lampante è forse quello delle ricette, ma lo stesso vale per molta manualistica illustrata, che può trattare i temi più diversi, da discipline pseudoscientifiche, esoteriche o salutistiche di vario tipo (dai tarocchi alla chiromanzia, dalla cristalloterapia ai fiori di Bach) a varie attività sportive, passando per il fai-da-te. In un contesto simile il traduttore è spesso costretto a tenere in considerazione due imperativi contrastanti: da un lato l'abbreviazione del testo di partenza, dall'altro la necessità di non privare il lettore di informazioni essenziali — informazioni che potrebbero avere, e qui sta la differenza rispetto ad altre pubblicazioni, un effetto reale sulla sua vita reale, nel momento in cui dovesse decidere di seguire le istruzioni contenute nel volume.
A quanto affermato finora si aggiunga che il necessario adattamento del testo di partenza non ha luogo solamente a livello formale: il traduttore avrà spesso la possibilità/obbligo di effettuare una revisione, almeno parziale, dei contenuti dei testi originali; un primo caso, piuttosto immediato, è quello della modifica gli elementi culturalmente connotati ivi espressi, spesso necessaria, per esempio, laddove per la spiegazione di un determinato comportamento da seguire si faccia uso, in originale, di analogie radicate nella cultura di partenza ma meno immediatamente comprensibili in quella d'arrivo.8 Nella manualistica di consumo questo caso è molto più comune di quanto si pensi; la metafora concettuale (nel senso assegnatole dal classico Lakoff/Johnson 1980) è d'altronde uno dei procedimenti più efficaci per introdurre in un certo ambito un concetto nuovo in maniera relativamente indolore. Nelle pubblicazioni a carattere prevalentemente didattico che costituiscono una parte importante della produzione che ci interessa in queste righe, questo aspetto diventa spesso preponderante. Se, in un'ottica comunicativa, questa forma di adattamento dei realia9 non può essere considerata specifica della realtà della coedizione, e risulta alquanto comune anche in volumi e scritti di altro genere — può avere un ruolo più o meno importante nella traduzione di ogni testo il cui carattere sia principalmente "pragmatico" (cfr. Delisle 1980) — nel caso che ci interessa un altro tipo di adattamento culturale può investire il testo a un livello più strutturale. In molti casi, per assicurare la vendibilità del prodotto-libro nel mercato di arrivo, intere parti di testo potranno essere redatte ex novo o fortemente riviste anche a livello concettuale, a causa di quella che talvolta si potrebbe definire come una vera e propria incompatibilità culturale tra gli autori/editori del testo di partenza e i fruitori del testo di arrivo. Due esempi a questo proposito, uno di carattere più puntuale e un altro sistematico: chi scrive si è occupato della versione italiana di un libro di ricette che invitava sistematicamente a lasciar bollire la pasta per 20 minuti, indipendentemente dal formato e da qualunque altro parametro;10 in questo caso un adattamento era assolutamente necessario se si desiderava fare in modo che il volume potesse essere distribuito in Italia senza conseguenze negative sulla credibilità dell'editore. Se qui ci troviamo comunque ancora nel campo dell'adattamento puntuale, volto a risolvere micro-problemi piuttosto specifici e, in linea di massima, facilmente superabili, esistono altri casi in cui il traduttore svolge un ruolo autoriale, riscrivendo in prima persona alcune parti testuali e adattandone altre in misura spesso considerevole. Un caso esemplare è quello di molta manualistica 'professionalizzante' in settori quali grafica, design, moda e così via, che passa spesso proprio attraverso la coedizione: pensati per studenti o principianti in cerca di orientamento, questi volumi offrono di frequente uno o più capitoli dedicati alla ricerca di lavoro o alle modalità di ingresso presso scuole e istituti in cui perfezionare le proprie conoscenze. Pensati chiaramente per il pubblico di partenza — come abbiamo visto, nella stragrande maggioranza dei casi inglese o statunitense — tali capitoli descrivono modalità di iscrizione, presentazione delle domande, test di ingresso e molti altri aspetti che non si applicano alle realtà di altri paesi. L'ovvia necessità di una riscrittura quasi completa si scontra, ancora una volta, con l'impossibilità di modificare il layout di partenza (che magari potrà inserire, spesso con intento puramente decorativo, immagini relative allo studio presso le scuole di maggiore prestigio, immagini totalmente fuori contesto se si decidesse di adattare il testo) e con le tempistiche di cui si è già detto, che non lasciano al traduttore/adattatore il tempo necessario per riscrivere da capo porzioni testuali anche piuttosto consistenti (la cui lunghezza dovrà essere determinata comunque dallo spazio a disposizione, quello cioè assegnato al tema dall'autore originale).
Un'ultima considerazione: le esigenze specifiche sopra elencate vanno chiaramente ad aggiungersi alle 'normali' competenze e abilità richieste al traduttore editoriale, quali la capacità di mantenere uno stile adatto al tipo di testo su cui è impegnato o un'adeguata competenza nella materia trattata. Entrambi questi punti possono essere alquanto spinosi, aggiungendo difficoltà ulteriori a quelle già viste. Nel primo caso, la stessa materia può essere trattata in maniera alquanto diversa nei diversi paesi: nella manualistica divulgativa che costituisce gran parte delle pubblicazioni che qui ci interessano, ogni cultura ha infatti convenzioni linguistiche specifiche, e adotta registri particolari e spesso ben codificati, rendendo necessario un nuovo tipo di adattamento, stilistico questa volta, per fare sì che il prodotto finale sia ben recepito nella cultura d'arrivo. Per quanto riguarda il secondo punto, invece, è necessario ricordare che gli editori di volumi illustrati tendono a compensare quella che dal punto di vista produttivo è già una notevole forma di specializzazione con un'analoga apertura dal punto di vista tematico. I cataloghi della maggior parte degli editori qui nominati11 offrono, fianco a fianco, prodotti molto diversi, che raccolgono tutte le tipologie testuali viste in precedenza (dalle ricette ai testi di botanica e giardinaggio, da grafica, design e architettura a diete, esoterismo, benessere e sport); chi lavori nel settore potrà quindi vedersi proporre, pur restando libero di rifiutare compiti al di là delle proprie possibilità, traduzioni molto diverse l'una dall'altra e spesso concernenti micro-ambiti dal lessico e dalle pratiche molto specifici, con un conseguente aumento delle ricerche necessarie e delle competenze extra-traduttive richieste.
5. Un campo aperto, qualche soluzione
Come si è visto nelle righe sopra, la coedizione richiede una figura dalle molteplici competenze e specializzazioni, capace di tradurre ma anche di scrivere e di adattare molteplici elementi (lunghezza, elementi culturalmente connotati, registro linguistico, informazioni presentate) per fare fronte a esigenze spesso discordanti. Nonostante l'assenza di dati recenti — le statistiche ISTAT, molto complete per altri versi, non permettono di scorporare i dati relativi ai volumi illustrati o alle coedizioni: forse un altro segno della scarsa attenzione per questa pratica — il settore appare in crescita e, se un tempo la coedizione era appannaggio di pochi editori di piccole dimensioni, la pratica pare essere sempre più comune, il che rende necessaria una maggiore consapevolezza delle sue specificità. Solo attraverso quest'ultima, in effetti, sarà possibile mantenere e idealmente incrementare gli attuali standard qualitativi, rendendo al contempo meno invadente l'aspetto globalizzante della coedizione. Un miglioramento della situazione attuale potrà avvenire essenzialmente attraverso due canali, percorribili in contemporanea: dal lato dell'importazione, la formazione di figure professionali in grado di raccogliere le sfide che questo tipo di lavoro impone. Si potrebbe pensare allora a una formazione ad hoc, che per esempio passi attraverso specifici moduli di insegnamento nei corsi di traduzione editoriale o nei vari master o corsi di formazione ai mestieri del libro. La reale necessità di una formazione specifica, ovviamente, dovrebbe dipendere dall'importanza relativa della coedizione rispetto al mercato editoriale nel suo complesso; l'attuale assenza di statistiche che permettano di quantificarla è, in questo senso, un primo punto da affrontare. Dal lato dell'esportazione, invece, gli editori hanno la possibilità di risolvere a monte alcuni dei problemi che si porrebbero più 'in basso' lungo la catena produttiva, di cui i traduttori sono uno degli ultimi anelli. In una lista non esaustiva dei vari accorgimenti che si potrebbero adottare vanno segnalati per lo meno tre aspetti, da indicare sinteticamente come segue:
- Lo spazio;
- Il colore;
- Il tempo.
Per quanto riguarda il punto (1), si potrebbe pensare alla creazione di layout dagli spazi bianchi un po' più ampi dello stretto necessario, di modo che nella resa verso lingue che hanno bisogno di maggiore spazio il testo non debba essere sacrificato, a tutto vantaggio della comprensibilità. Un ulteriore stratagemma (2) potrebbe essere costituito dal ricorso al solo bianco e nero nelle parti interculturalmente più 'problematiche' del testo come, nei manuali, quelle relative alla formazione; in questo modo, pur mantenendo una grafica sostanzialmente identica, ogni editore straniero potrebbe localizzare a modo proprio capitoli che altrimenti perderebbero gran parte del proprio interesse per i lettori della cultura d'arrivo, arrivando nel caso a sostituire anche le immagini con nuove foto, sempre in bianco e nero. L'aspetto relativo all'adattamento dei contenuti ci porta poi a (3) la concessione ai coeditori di un tempo sufficiente a svolgere adattamenti e localizzazioni in maniera adeguata — tra tutti gli aspetti legati alla qualità, quello forse più banale ma, troppo spesso, il più trascurato.
Come si è visto, l'ambito della coedizione lascia oggi aperte numerose questioni. Queste investono in primo luogo il macro-ambito editoriale nel suo complesso, in particolare dal punto di vista economico e culturale: specialmente evidente risulta l'aspetto globalizzante di questo tipo di pratica, che però, come si è visto, possiede al suo interno i germi della sovversione dei consueti rapporti egemonici. Numerose sono anche le specificità della coedizione internazionale al micro-livello della singola traduzione. Il ruolo del traduttore appare decisamente peculiare e richiede il possesso di competenze che esulano da quanto normalmente ci si aspetta dalla sua figura. Molti dei problemi derivanti da questo fatto, comunque, potrebbero essere risolti in modo relativamente semplice lavorando sulla formazione dei traduttori e sull'elaborazione dei testi che entreranno a far parte di questo meccanismo editoriale.
Le poche righe del nostro intervento, ce ne rendiamo conto, non sono certo sufficienti a offrire un panorama completo di una pratica ancora poco studiata; speriamo che, per lo meno, possano contribuire allo sviluppo di ulteriori indagini e alla crescita di attenzione verso un ambito ancora poco studiato e piuttosto nebuloso.
Bibliografia
- Arosio, Fabrizio Maria (a cura di) (2002). La produzione libraria nel 2000, Roma: ISTAT.
- Bastin, Georges (1993). "La notion d'adaptation en traduction." Meta 38 (3): 473-478.
- — (2001). "Adaptation." Mona Baker (ed.) (2001). Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London/New York: Routledge, 5-8.
- Cronin, Michael (2003). Translation and Globalization, London/New York. Routledge.
- Delisle, Jean (1980). L'Analyse du discours comme méthode de traduction, Ottawa: Editions de l'Université d'Ottawa.
- Lakoff, George e Mark Johnson (1980). Metaphors We Live By, Chicago: Chicago University Press.
- Mistretta, Enrico (2006). L'editoria. Un'industria dell'artigianato, Bologna: Il Mulino.
- Munday, Jeremy (2001). Introducing Translation Studies: Theories and Applications, London/New York: Routledge.
- Nord, Christiane (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained, Manchester: St Jerome.
- Owen, Lynette (2001). Selling Rights, London/New York: Routledge.
- Peresson, Giovanni (2005). Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2005, Roma: Associazione Italiana Editori.
- Robin, Christian (2003). "La gestion et le contenu des livres." Les Enjeux de l'information et de la communication n°4. Online all'indirizzo http://w3.u-grenoble3.fr/ les_enjeux/2003/Robin/index.php (16.04.2010).
- Syndicat National de l'Edition (SNE) (senza data). Online all'indirizzo http://www.sne.fr/pages/editeur-un-metier/realiser-un-livre/coedition.html (10.04.2010).
- Venuti, Lawrence (1998). The Scandals of Translation, London/New York: Routledge.
Biografia
 Fabio Regattin, dottore di ricerca in scienza della traduzione e professore a contratto di lingua francese presso l'Università di Bologna, lavora come traduttore editoriale e teatrale. Si interessa in particolare alla traduzione per il teatro e alla traduzione dei giochi di parole, temi sui quali ha scritto alcuni articoli e un volume (Le Jeu des mots. Réflexions sur la traduction des jeux linguistiques,Emil, 2009).
Fabio Regattin, dottore di ricerca in scienza della traduzione e professore a contratto di lingua francese presso l'Università di Bologna, lavora come traduttore editoriale e teatrale. Si interessa in particolare alla traduzione per il teatro e alla traduzione dei giochi di parole, temi sui quali ha scritto alcuni articoli e un volume (Le Jeu des mots. Réflexions sur la traduction des jeux linguistiques,Emil, 2009).
Note 1:
D'ora in avanti, e in assenza di indicazioni contrarie, con il termine 'coedizione' faremo riferimento alla categoria, più ristretta, delle coedizioni internazionali.
Return to this point in the text
Note 2:
Il numero delle persone coinvolte nella realizzazione di un volume illustrato fa sì che i colophon di questo tipo di pubblicazioni assomiglino talvolta, per estensione, ai titoli di coda delle produzioni cinematografiche; abbiamo sotto mano il volume One Thousand Languages, edito da Ivy Press, una delle case leader nel settore, che conta per esempio le seguenti voci: Creative Director, Publisher, Editorial Director, Art Director, Senior Project Editor, Senior Art Editor, Design, Cover Design, Map Creation, Picture Researchers (e questo senza contare il curatore e gli autori dei diversi contributi che formano il volume, o, ancora — nel caso di eventuali traduzioni in altre lingue — dei traduttori!).
Return to this point in the text
Note 3:
Un fatto che risulta ancor più importante se si considera che difficilmente i libri di questo genere raggiungono picchi di vendita altissimi: una tiratura media, per un paese come l'Italia, può facilmente essere inferiore al migliaio di copie e raramente supera le 2500-3000 copie (per alcune serie di illustrati per l'infanzia Logos, casa editrice con cui collabora l'autore di queste righe, stampa in italiano 3-500 copie a titolo); appare evidente che, se ci si limitasse al mercato italiano, l'edizione si farebbe in perdita anche nel caso in cui le tirature andassero sempre esaurite.
Return to this point in the text
Note 4:
Si vedano anche le discussioni più dettagliate infra, nelle sezioni "La coedizione: un caso esemplare di globalizzazione" e "La coedizione per il traduttore: traduzione, adattamento?".
Return to this point in the text
Note 5:
Un'indicazione che sembra sconfessare i nostri timori giunge da Christian Robin, che in seguito a un'indagine comparativa su volumi illustrati pubblicati in Francia nel 1980 e nel 2001 può affermare che "la qualité formelle du texte est bien meilleure en 2001 qu'en 1980 alors que nous prévoyions au mieux une stabilité" (cfr. Robin 2003). Un simile dato non appare tuttavia rilevante in quanto il miglioramento è riscontrato sulla "qualità formale," in precedenza definita come "orthographe, style, typographie et ponctuation;" per tutti questi elementi la correzione può essere in gran parte deputata a strumenti elettronici indisponibili in passato, che bastano a spiegare il miglioramento; un'analisi dei contenuti, certo più complicata, potrebbe fornire indicazioni diverse. Non disponendo di dati certi in merito, ci limitiamo qui a segnalare, comunque, l'adozione sempre più diffusa di pratiche editoriali che non contribuiscono certo a migliorare la qualità complessiva della produzione libraria.
Return to this point in the text
Note 6:
"The status of translation in the global economy [...] calls attention to the unequal cultural exchange that involves the exploitation of foreign print and electronic media and the exclusion and stereotyping of foreign culture at home;" [it] "establish[es] a hierarchical relationship between the major and minor languages, between the hegemonic and subordinate cultures" (Venuti 1998: 159 e 165).
Return to this point in the text
Note 7:
Non siamo in grado, viste le nostre scarse conoscenze del settore, di affermare con certezza assoluta che gli spazi assegnati alle diverse aree geografiche non riflettano con esattezza il panorama vitivinicolo mondiale; resta il fatto che, nel momento in cui si importa un testo di questo tipo in un altro paese, il nuovo pubblico a cui esso si rivolgerà deve essere tenuto nella debita considerazione, se non altro per ragioni commerciali; e, in quest'ottica, può darsi che un'espansione delle pagine dedicate all'Italia sarebbe stata, per il pubblico italiano, un fattore interessante e commercialmente apprezzabile.
Return to this point in the text
Note 8:
Lo stesso, come indica esplicitamente anche Georges Bastin in entrambi i testi segnalati in bibliografia, vale per la presenza nell'originale di elementi metalinguistici. Per esempio, la spiegazione riguardante la pronuncia di un certo termine in una lingua diversa da quella della redazione del testo, parte del lessico specifico di una disciplina o di una pratica sportiva, potrebbe offrire una 'trascrizione fonetica' in inglese; l'etimologia di una parola latina, spiegata perché difficilmente accessibile a un lettore anglofono, potrebbe risultare evidente per un italofono; o, viceversa, all'interno di un gergo tecnico la derivazione di un termine da un altro dall'uso più comune potrebbe apparire, in assenza di una traduzione e di una spiegazione più accurata, totalmente opaco a un lettore che non conosce l'inglese. L'adattamento necessario in questi casi è tuttavia comune a qualunque genere di testo, e non ci sembra offrire un interesse specifico nell'ambito della coedizione.
Return to this point in the text
Note 9:
Si veda anche, a questo proposito, l'esempio del "potato masher" e delle sue traduzioni in olandese, italiano, francese e spagnolo in Munday 2001: 86.
Return to this point in the text
Note 10:
È chiaro che in questo e in numerosi altri casi simili ci si potrebbe interrogare, in primo luogo, sull'opportunità stessa di pubblicare volumi evidentemente inadatti al mercato d'arrivo; tali decisioni, tuttavia, non spettano al traduttore, che dovrà cercare di ottenere il meglio a partire dal materiale che ha a disposizione.
Return to this point in the text
Note 11:
Con l'eccezione di alcune case editrici che si occupano solamente di opere di tipo artistico-letterario (letteratura per l'infanzia, albi prodotti da illustratori di fama...).
Return to this point in the text